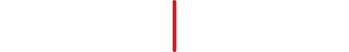Com’’è noto, con l’ordinanza n.207/2018 e con la sentenza n.242/2019 sul caso Cappato/Antoniani, la Corte Costituzionale ha individuato alcune aree di non punibilità delle condotte di aiuto al suicidio, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi – con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della L. n. 219 del 2017 ‘Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente“.
Il giudice costituzionale ha pure espresso l’auspicio che la materia fosse oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore statale, che ancora rimane inerte.
Tale inerzia è grave ove si consideri il quadro sempre più caotico e disomogeneo che sembra profilarsi a seguito delle decisioni della Corte: basti pensare al fatto che, in presenza dei presupposti indicati dalla sent. n. 242/2019, alcuni giudici hanno escluso, a fronte di altri che hanno affermato, la sussistenza del dovere dell’azienda sanitaria di offrire la prestazione di aiuto al suicidio, con la somministrazione di farmaci utili allo scopo, con conseguente grave disparità di trattamento tra pazienti che versavano in condizioni simili.
Dal punto di vista giurisprudenziale, si sono registrate decisioni contrastanti: si pensi anche al caso di un paziente affetto da sclerosi multipla morto con il suicidio assistito in Svizzera nell’aprile 2017, in relazione al quale pure la Corte d’Appello di Massa e la Corte d’Assise d’Appello di Genova, si sono espresse per una interpretazione del mantenimento in vita attraverso trattamento di sostegno vitale, estendendolo a qualsiasi trattamento e intervento, anche di assistenza, in ambito sanitario (terapia farmacologica, assistenza di personale sanitario o non sanitario, ausilio di qualsiasi macchinario medico); in Sicilia, invece, la Corte d’Assise d’Appello di Catania ( Corte d’assise d’appello di Catania, sent. 12 luglio 2023, n. 13), ha condannato il presidente dell’associazione Exit-Italia, per istigazione al suicidio per il ricorso al suicidio assistito in Svizzera nel 2019 di una donna, capace di intendere e di volere, affetta da depressione e da sindrome di Eagle, non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Il DDl dell’Assemblea Regionale Siciliana sull’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Adeguarsi e non sforzarsi
L’Assemblea Regionale Siciliana ha attualmente in discussione un DDL che, come le diverse proposte di legge finora presentate in altre regioni, al momento converge sul modello standard predisposto dall’Associazione Coscioni, dal quale emergono almeno tre elementi comuni rilevanti al fine di valutarne la fondatezza:
- la necessità di un intervento normativo regionale, volto a dettagliare i tempi e i modi del procedimento aperto a seguito dell’intervento del giudice costituzionale, in attuazione della sentenza della Corte Cost. n.242/2019;
- l’avvenuto riconoscimento a mezzo della sentenza Cappato/Antoniani di un “diritto soggettivo al suicidio assistito” (art 1, comma 2, DDL) e conseguente introduzione di una nuova prestazione, l’assistenza medicale al suicidio, a carico del SSN, da fornire gratuitamente a chi si trovi nelle condizioni previste dalla Corte;
- la competenza legislativa regionale in virtù della materia concorrente ‘tutela della salute’, ex art.117, comma 3, Cost.).
A parere di chi scrive, nessuno dei predetti presunti presupposti legittimanti appare convincente.
Filippo disse al funzionario Etiope “Capisci quello che stai leggendo?” (At 8, 26-40)
Il Disegno di legge ricopia quasi fedelmente quella denominata “Liberi Subito” dell’Associazione Luca Coscioni, che reca “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale”.
Si giustificherebbe così l’intervento regionale per la perdurante inerzia del legislatore statale che imporrebbe, dunque, una supplenza regionale volta a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale. Sarebbe quindi ritenuta implicita la doverosa attuazione della sentenza n.242/2019 da parte del legislatore regionale.
Orbene dalla semplice lettura delle decisioni del giudice costituzionale si può escludere che le stesse fondino un potere/dovere d’intervento in supplenza dei legislatori regionali di intervenire per darvi attuazione, posto che la Corte sollecita solo l’intervento del legislatore nazionale, vero interlocutore del giudice delle leggi, in ragione delle materie e degli interessi coinvolti in una legislazione sul suicidio medicalmente assistito che ricade nella sfera di competenza legislativa esclusiva statale .
In secondo luogo, non sussiste l’affermata necessità di disciplinare con legge regionale i modi del procedimento che le amministrazioni sanitarie devono seguire, posto che le modalità della prestazione richiesta alle autorità sanitarie in relazione alla fase di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona può chiedere aiuto al suicidio, sono già ricavabili dalla procedura medicalizzata di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 219/2017.
La Corte ha fatto ricorso a tale punto, in attesa dell’intervento del Parlamento, proprio in ragione del fatto che l’intervento del giudice delle leggi è circoscritto “in modo specifico ed esclusivo all’aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che già potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge stessa”.
Tra l’altro riconoscere l’eventuale approvazione di diverse leggi regionali in tale senso non garantirebbe l’uniformità di contenuto, specialmente per quanto attiene alla regione siciliana ed alla sua specialità e quindi nessuna uniformità di disciplina nei vari territori regionali può essere garantita atteso che attualmente ci sono alcune regioni ancora ferme su tale fronte , altre in cui è stata presentata una proposta in parte diversa da quella ‘Liberi Subito’, altre che l’hanno già bocciata.
Esiste un diritto soggettivo al suicidio assistito e un obbligo di prestazione dell’assistenza medicale al suicidio in capo alle strutture del SSN?
Come sopra indicato l’art.1 del Disegno di legge regionale chiarisce subito che esiste il “diritto all’erogazione dei trattamenti” come individuale e inviolabile, che non può essere limitato, assoggettato a condizioni o altre forme di controllo ulteriori e diverse da quelle previste dalla medesima proposta di legge.
L’art. 3, co. 5, dispone, poi, che “le aziende sanitarie regionali, “forniscono il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza medica per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato presso una struttura ospedaliera, l’hospice o, se richiesto, il proprio domicilio“.
Infine, si garantisce la gratuità delle prestazioni e dei trattamenti previsti dalla stessa proposta di legge nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito (art. 5), precisando, altresì, all’art. 6 “Norma finanziaria“, la non necessità di una speciale copertura per la legge proposta, per i cui costi si deve, pertanto, provvedere secondo le ordinarie modalità di finanziamento dei servizi.
Ebbene, l’intero impianto normativo si fonda sul presupposto di un presunto riconoscimento da parte della citata giurisprudenza costituzionale di un vero e proprio diritto a ricevere assistenza al suicidio a fronte del quale sussisterebbe un obbligo di erogazione di una prestazione gratuita a di assistenza medicale al suicidio da fornire a chi si trovi nelle condizioni previste dalla Corte stessa.
In realtà, premettendo la difficoltà di desumere con certezza dal complesso iter argomentativo della sentenza n. 242/2019 l’esistenza di un diritto di darsi la morte o di ricevere assistenza per ottenerla, cui corrisponderebbe l’obbligo di prestazione in capo al Sistema Sanitario di organizzare procedure sistematiche finalizzate a procurare la morte con farmaci letali, non si ritiene sussistente tale diritto soggettivo.
Perché possa parlarsi di diritto al suicidio, dunque, dovrebbe sussistere un obbligo, gravante su altri, di agevolare il proposito suicida o quantomeno di non ostacolarlo.
L’art. 2 Cost. – ed anche l’art. 2 CEDU – impongono allo Stato il dovere di tutelare la vita di ogni individuo, non quello – diametralmente opposto di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire.
Gli interventi della Corte non criticano tale impostazione sul tema del fine vita questi hanno ribadito, infatti, la perdurante compatibilità costituzionale dell’incriminazione dell’aiuto al suicidio, salvo che nella peculiare ipotesi in cui a chiedere aiuto a morire sia “una persona a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che trovi assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.
La sentenza n. 242/2019, invero, non riconosce un diritto al suicidio, bensì la mera facoltà di richiedere aiuto per compierlo, senza che l’agevolatore possa essere incriminato.
Non si tratta di un diritto, come si evince dalle argomentazioni della Corte, dalle quali non emerge in alcun modo ed in nessun caso un dovere di rispondere positivamente a tale richiesta di anticipazione innaturale della morte.
Ciò è proprio confermato dalle parole della stessa Corte “resta affidato [..] alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, ad esaudire la richiesta del malato”, dal momento che “la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici” (sent. 242/2019, n. 5 e 6 Considerato in diritto)
Ricordiamo l’ambito che è quello della depenalizzazione dell’aiuto al suicidio in quei soli casi indicati , ma ciò non fonda alcun obbligo, dovere o esigibilità dell’aiuto al darsi la morte.
Dal punto di vista prettamente giuridico la posizione soggettiva della persona intenzionata a porre fine alla propria vita, non è elevata a diritto soggettivo ma a mera aspettativa, né la stessa libertà di autodeterminazione del malato nelle scelte delle terapie ex artt. 2, 13, 32 Cost., può fondare alcun dovere di presa in carico della salute e dell’autodeterminazione terapeutica degli assistiti da parte dell’amministrazione.
Sarebbe un paradosso riconoscere al singolo medico la libertà di non prestare aiuto al suicidio, mentre le strutture pubbliche del servizio sanitario sarebbero obbligate a garantirlo.
Anche forzando l’interpretazione delle decisioni del giudice delle leggi con il riconoscimento di un diritto di libertà a autodeterminare la propria morte ciò non potrebbe conmtenere un diritto a prestazioni sociali in tal senso, non imponendo alcuna prestazione positiva da parte dell’amministrazione sanitaria, né in capo a terzi privati né a soggetti pubblici.
Ad un presunto diritto ad autodeterminare la propria morte non corrisponde alcun dovere a supportarla materialmente e solidaristicamente. Si tratta di una scelta affidata alla cooperazione dei singoli.
Se ciò è corretto, la disciplina di tale presunta nuova prestazione di assistenza medicale al suicidio a carico del servizio sanitario, non può sussistere.
Così come perde di fondamento il successivo art. 2 che prevede che “Fino all’entrata in vigore della disciplina statale, possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito di cui alla presente legge le persone: a) affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che le stesse reputano intollerabili; b) tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale; c) pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli; d) che esprimono un proposito di suicidio formatosi in modo libero e autonomo, chiaro e univoco”.
Si richiamano i soggetti che versano nelle condizioni indicate nella sentenza n. 242/2019, ma mentre per il giudice costituzionale costoro possono chiedere che vengano poste in essere le verifiche propedeutiche al riconoscimento della scriminante sporadica ivi prevista, nel Ddl in esame diventano coloro i quali ‘possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito”, la cui erogazione diviene un obbligo a carico del SSN solo perché disposto dalla legge regionale stessa, in assenza di competenza in tale direzione come si dirà di seguito.
La presunta competenza legislativa regionale in tale materia
Nella relazione illustrativa del Disegno di legge si dà per scontata la competenza legislativa regionale in tema di suicidio assistito. A tal fine, si richiamano le disposizioni costituzionali concernenti la sanità pubblica, in particolare l’art. 117, co. 2, lett. m), che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e l’art. 117, co. 3, che, invece, attribuisce alla competenza concorrente la materia “tutela della salute“.
In primo luogo appare molto discutibile e tecnicamente inesatto supportare un DDL regionale su una “comunicazione del Capo di Gabinetto dell’ex Ministro della Salute” e dalla lettera del 2022 dell’allora Ministro della Salute, atti che non sono tecnicamente fonti giuridicamente rilevanti e di supporto di una proposta di legge (Pag. 2 e 3 DDL).
Inoltre si confonde la verifica delle condizioni per il suicidio assistito, con il diritto (inesistente) ad ottenere direttamente dalle strutture sanitarie i mezzi per darsi la morte, per cui l’eventuale competenza legislativa regionale a disciplinare procedure e tempi di applicazione di tale presunto diritto .
Il Ddl richiama la tutela della salute, ex art.117, co. 3, che, in effetti consente alle regioni, nell’esercizio della potestà legislativa ripartita o concorrente, di introdurre norme organizzative e procedurali per l’erogazione di prestazioni sanitarie (cfr. Corte Cost. sent. n. 338 del 2003).
Si pone in essere una prima contestazione costituita dall’impossibilità di ritenere che l’assistenza al suicidio si configuri come terapia (che per definizione è volta ad una guarigione) o come atto/attività medica di tutela della salute (che se così è è orientato alla vita) e quindi invocare tale competenza concorrente.
Inoltre occorre sottolineare l’incoerenza dei richiami costituzionali posti in essere.
La Corte ha affermato che nelle materie di potestà concorrente il legislatore regionale può anticipare il suo intervento nell’inerzia del legislatore statale, ma non si può dimenticare che nel particolare ambito della materia concorrente della ‘tutela della salute’, la Corte Costituzionale stessa ha escluso – in difetto di principi fondamentali posti a livello statale – la legittimità di attività legislative regionali “suppletive’ o ‘sostitutive”, sicché la legge regionale che intervenga in tale situazione presenta un vizio di competenza in senso stretto ed è dichiarata illegittima perché invasiva di una riserva, per lo sconfinamento nell’area dei principi fondamentali, e dunque per ciò che essa disciplina e non già per come disciplina il suo oggetto (Cfr per esempio la decisione n. 438/2008).
In tale ambito non esistono, né si possono desumere dalla pronunzia della Corte, principi fondamentali della materia “suicidio medicalmente assistito” posti ovvero desumibili dalle leggi statali;
La competenza legislativa regionale anche per le regioni a statuto non possono incidere sul delicatissimo aspetto delle garanzie costituzionali relative al diritto alla salute creando una diritto di fine della vita procurato.
Il disegno di legge esaminato appare quindi di dubbia legittimità costituzionale, poiché finisce per disporre dei principi fondamentali della materia riservati, ai sensi dell’art.117, co. 3, Cost. alla legislazione statale, possibilità esclusa dalla consolidata giurisprudenza costituzionale.
Peraltro, la necessità del previo intervento del legislatore statale in tale delicato campo si desume anche dagli altri titoli competenziali chiamati in causa da una legislazione in tema di suicidio medicalmente assistito: rileva non solo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ex art. 117, co. 2, lett. m) (richiamata anche dai redattori del Ddl), ma anche l’ordinamento civile e penale ex art.117, co. 2, lett. l), titoli inevitabilmente implicati da norme che intervenengono sulle condizioni di accesso in via anticipata alla morte.
Ciò colpisce i diritti “personalissimi” del diritto alla vita e all’integrità tutelati anche in sede civile. Ed è appena il caso di sottolineare che rispetto a tali materie di competenza esclusiva dello Stato in nessun modo è invocabile alcuna supplenza (cfr Corte Cost. sent. n. 1/2019 e si veda anche il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 15 novembre 2023)
In forza di quanto detto l’intervento dei legislatori regionali, limitatamente agli spazi di competenza ad essi riservato, sarebbe consentito soltanto a seguito dell’intervento dello Stato nelle materie allo stesso riservate in via esclusiva in grado di interferire con i diritti personalissimi.
La Relazione illustrativa del ddl de quo contiene anche un richiamo ai LEA, livelli essenziali di assistenza, (“… che le regioni possono determinare l’inserimento nei LEA regionali della prestazione lecita” pag. 3).
Orbene tale previsione può provocare inevitabili asimmetrie che finirebbero per accentuare le anomalie del federalismo sanitario, causa di potenziali discriminazioni derivanti dal luogo di residenza dell’interessato. A ciò si aggiunga che la liceità della prestazione è strettamente contenuta nei limiti di cui al giudicato costituzionale, ma è evidente che i fondi eventualmente dirottati per realizzare assistenza al suicidio verrebbero sottratti ad altre voci di spesa sanitaria. Sia consentito il sospetto che in tal modo si possa attingere proprio ai fondi stanziati per le cure palliative e la terapia del dolore riconosciuti come diritto dalla legge n.38/2010 e le cui prestazioni sono regolarmente inserite nei LEA dal 2017, dirottandole verso presunte prestazioni non fondate da un diritto soggettivo.
La priorità assoluta per le politiche della sanità deve essere la garanzia delle cure palliative che ancora sconta molti ostacoli e difficoltà, specie nella disomogeneità territoriale dell’offerta e nella mancanza di una formazione specifica nell’ambito delle professioni sanitarie
In ordine alle disposizioni organizzative: “Abbondandis in abbondandum” diceva Totò
Il Ddl legge prevede che la verifica dei predetti requisiti venga svolta da una Commissione medica multidisciplinare permanente (art. 3 Istituzione della Commissione medica multidisciplinare permanente), di cui si prevede l’istituzione presso le aziende sanitarie regionali quale organo deputato ad effettuare le verifiche mediche relative alla sussistenza delle condizioni di accesso e alle migliori modalità di esecuzione dell’aiuto alla morte volontaria indicate dalla Corte costituzionale.
Il Ddl introduce un organo non previsto o suggerito nella sentenza n. 242/2019 che ha riservato alle strutture sanitarie esistenti “la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio”, e la verifica delle “relative modalità di esecuzione”, che dovranno essere “tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze”ed a tal fine ha richiesto l’intervento di un organo collegiale terzo, che possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità”, individuato, nelle more dell’intervento del legislatore statale, nei Comitati Etici Territorialmente competenti.
La scelta di istituire un nuovo organo di derivazione regionale (sia pure prevedendo il successivo parere del CET), appare errata perché potrebbe portare ad una divaricazione territoriale nella valutazione dei requisiti fissati dalla Consulta.
L’art. 3, co. 5, prevede che “le aziende sanitarie regionali, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), forniscono il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza medica per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato presso una struttura ospedaliera, l’hospice o, se richiesto, il proprio domicilio” Disposizione questa che appare illegittima perché tale scelta rientra tra quelle espressamente riservate dal giudice costituzionale all’intervento del legislatore nazionale.
Alla luce delle predette considerazioni il Ddl in commento appare di dubbia legittimità costituzionale. A fronte di ciò si auspica che nell’attuale assetto giuridico-normativo si giunga, soprattutto a livello nazionale, a interventi che tutelino e favoriscano l’accompagnamento e la cura nella malattia, sostengano le famiglie nelle situazioni di sofferenza mediante l’erogazione uniforme di quelle prestazioni che rappresentano un modo concreto per alleviare la sofferenza e per assicurare dignità sino alla fine.
Conclusione
Le precedenti considerazioni non vogliono costituire un mero esercizio di stile, bensì un modesto contributo alla ricerca di una soluzione costituzionalmente corretta.
Non si può ignorare la sofferenza di coloro che, colpiti da patologie irreversibili e da dolori fisici o psicologici intollerabili, manifestano il desiderio di porre fine alla propria esistenza. A queste persone ed ai loro familiari, va tutto il rispetto e la vicinanza che si deve a chi affronta con dignità una prova estrema.
Tuttavia, la delicatezza del tema impone che ogni intervento legislativo sia condotto nel pieno rispetto dei principi costituzionali e delle competenze che l’ordinamento assegna al legislatore statale ed a quelli regionali, evitando l’avventurarsi in materie che incidono sui diritti fondamentali e personalissimi della persona senza una cognizione piena di ciò su cui si legifera .
Tale rispetto impone che ogni studio, proposta di legge, o qualsiasi altro scritto dedicato a tale tema sia privo colore politico e di posizioni di natura religiosa che restano patrimonio dei singoli cittadini e non dello Stato.
Soprattutto, non deve essere affrontato in modo sbrigativo per non scontare quell’appiattimento culturale di cui parla Roy nel suo noto saggio “l’Appiattimento del mondo”.
Forse così sarà possibile contemperare il dovere di vicinanza verso chi soffre con l’altrettanto indispensabile rispetto dell’ordine costituzionale e della dignità della vita e delle scelte di ciascuno.