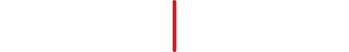Il cambiamento climatico non è più una previsione per le prossime generazioni: è una realtà che condiziona già oggi le vite delle persone. Ondate di calore, crisi idriche, desertificazione e instabilità alimentare mettono a rischio soprattutto le comunità più fragili. «I nostri politici sono intrappolati nella tirannia dell’adesso, mentre noi abbiamo bisogno di sviluppare una visione di lungo periodo», ha spiegato il filosofo sociale Roman Krznaric, invitando a uscire dalla logica dell’emergenza continua per abbracciare una prospettiva più ampia .
Guardare al passato per immaginare il futuro
La Storia insegna che i grandi cambiamenti non arrivano sempre per via graduale. L’abolizione della schiavitù, i diritti civili negli Stati Uniti o l’indipendenza dell’India mostrano che spesso è stata la forza dei movimenti collettivi a ribaltare sistemi radicati. «Le rivoluzioni avvengono quando cambiano i paradigmi», ricordava Thomas Kuhn, e il tema climatico non fa eccezione.
Se in passato ribellioni, lotte sociali e proteste hanno accelerato svolte epocali, oggi la crisi climatica reclama la stessa energia dirompente. Non bastano pannelli solari e qualche riforma verde: serve un cambiamento strutturale che coinvolga la società nel suo insieme.
Oltre il gradualismo: verso nuovi modelli
Il rischio più grande è credere che piccoli aggiustamenti possano bastare. Negli ultimi decenni, nonostante conferenze internazionali e piani d’azione, le emissioni continuano a crescere e la soglia di 1,5 °C si allontana sempre più. «Armeggiare con le politiche pubbliche e montare qualche turbina eolica non è sufficiente», ha ammonito Krznaric.
Il punto è ridisegnare l’intero sistema: dall’energia all’alimentazione, dall’economia ai rapporti sociali. In questo senso, l’esperienza storica offre modelli alternativi: dall’economia circolare del Giappone del XVIII secolo alle cooperative dell’Emilia-Romagna nel XIX, fino alle comunità energetiche di oggi che ridanno potere alle persone e non solo ai grandi player industriali.
La speranza radicale
Parlare di speranza, in tempi di crisi, può sembrare ingenuo. Eppure, come sostiene lo stesso Krznaric, «non sono ottimista sulle prospettive della nostra specie, ma credo nella speranza come impegno verso i propri valori, anche quando le possibilità sembrano ridotte» .
È questa la speranza radicale: agire “come se” il cambiamento fosse possibile, perché l’alternativa è la rassegnazione. Una speranza che diventa forza collettiva quando associazioni, comunità locali e cittadini scelgono di unirsi in movimenti ecologici capaci di scardinare l’immobilismo politico e proporre soluzioni concrete.
La lezione è chiara: la crisi climatica non si vince con riforme graduali. Solo movimenti ecologici dirompenti, radicati nella giustizia sociale e nella solidarietà, possono aprire la strada a un futuro più equo, resiliente e sostenibile.